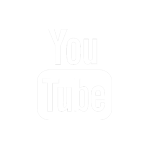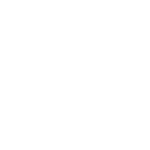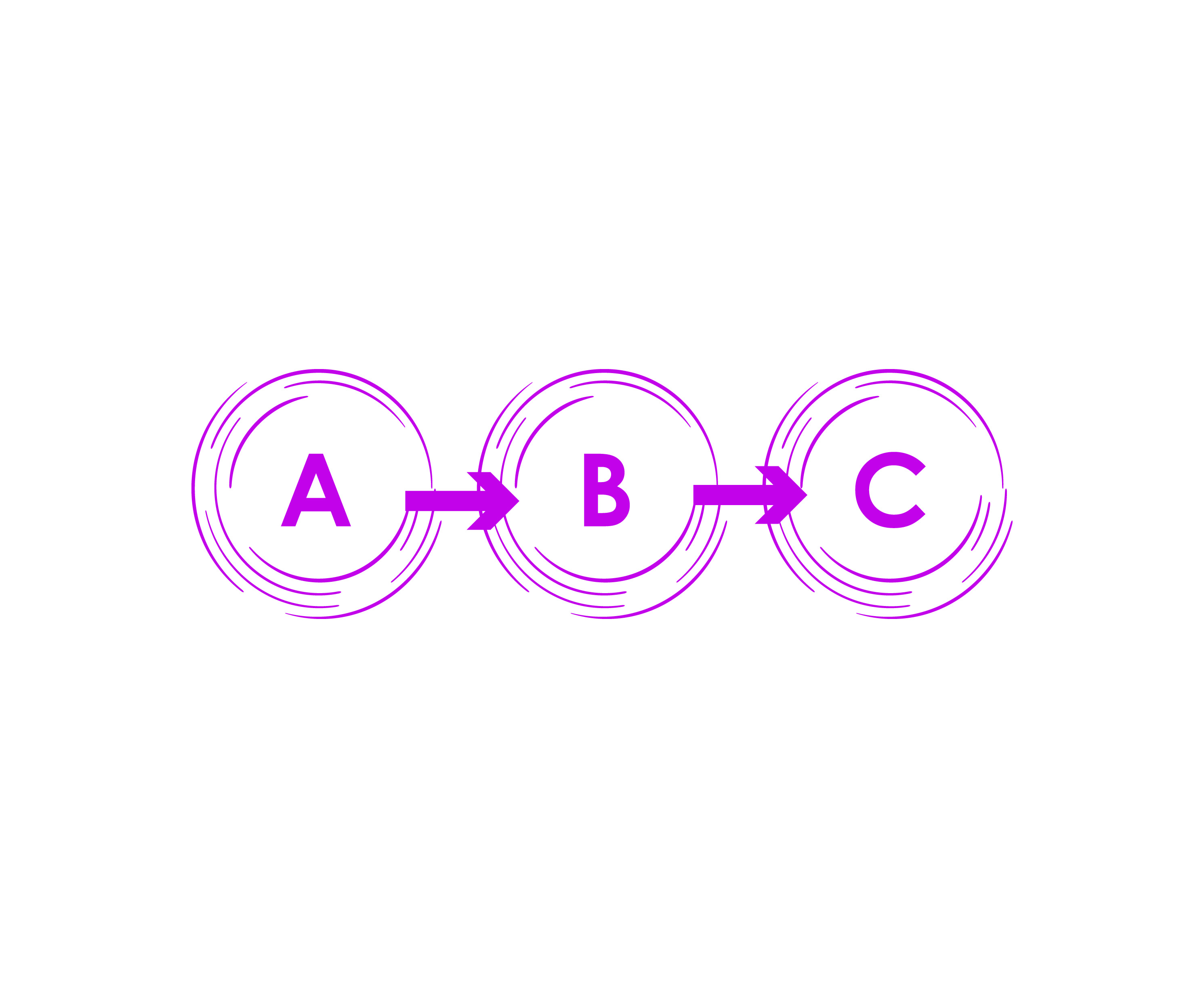La Terapia Cognitiva (CT) è una forma di psicoterapia centrata sulle distorsioni del pensiero rispetto a ciò che la maggior parte degli individui considererebbe un modo realistico di pensare e di interpretare la realtà.
A.T. Beck (1921-), che della terapia cognitivista è il maggior rappresentante, sostiene che il modo in cui le persone interpretano le loro esperienze ha un impatto significativo sulle loro emozioni, motivazioni e comportamenti. Obiettivo della terapia, attraverso il ricorso a tecniche cognitivo-comportamentali, è eliminare le distorsioni cognitive per favorire un tipo di pensiero più realistico.
Anche se in linea teorica possono esistere forme di terapia "esclusivamente cognitiva", nella pratica clinica si opera molto spesso una congiunzione funzionale tra gli approcci cognitivi e quelli comportamentali (CBT). Alcuni dei principali approcci sono:
- gli approcci cognitivisti classici di Beck;
- la Rational-Emotive Behavioural Therapy (REBT) di A. Ellis (1913-2017);
- gli approcci del secondo cognitivismo, o neocognitivismo clinico di impronta costruttivista, derivati dal lavoro pionieristico di G. Kelly (1905-1967).
Mentre gli approcci classici sono fortemente influenzati dai rigidi approcci del cognitivismo, all'interno degli approcci cognitivo-costruttivisti sono maggiormente integrati i contributi della teoria sistemica e della teoria dell'attaccamento di J. Bowlby (1907-1990).
Oggi la psicoterapia cognitivo-comportamentale sta vivendo quella che comunemente viene definita "terza ondata", dopo quelle del comportamentismo e del cognitivismo, che non si presenta come punto di rottura con il passato ma si mescola con naturalezza con quello che già esiste portando frutti di novità e ampliando le tecniche di intervento al disagio psicologico:
- la Mindfulness, che si colloca all'opposto dei tentativi logico-razionalisti di modificare comportamenti e pensieri attraverso il dialogo socratico bensì promuove l'accettazione e la flessibilità psicologica;
- la Acceptance and Commitment Theory (ACT), secondo cui non è tanto il contenuto dei pensieri ad influenzare il disagio e la sofferenza, quanto l'atteggiamento che abbiamo nei confronti di essi;
- la Metacognizione, cioè la capacità di comprendere i pensieri, le emozioni, le cause psicologiche dei propri comportamenti disfunzionali per promuovere ed affinare la capacità di capire cosa gli altri pensano, provano e cosa li muove ad agire, promuovendo modi di relazionarsi più funzionali;
- i Sistemi Motivazionali Interpersonali (SMI) di G. Liotti (1945-2018), quali tendenze universali, biologicamente determinate e selezionate su base evolutiva la cui espressione nel comportamento presenta variabilità individuali;
- la Schema Therapy (SM) di E. Young (1950-), che cerca di cogliere le tematiche che si nascondono dietro i sintomi e gli stili di coping che ognuno sviluppa per fronteggiare o evitare le emozioni intense.
Il trattamento psicoterapico include una combinazione di interventi verbali e di tecniche di modificazione del comportamento che aiutano il paziente a identificare le proprie cognizioni disfunzionali. Il paziente viene quindi aiutato a rielaborare queste cognizioni, e i conseguenti "schemi maladattivi", che sono alla base di alcuni dei suoi processi disfunzionali.
BIBLIOGRAFIA
Beck A.T., Cognitive Therapy and Emotional Disorders, International University Press, New York, 1976
Guidano V.F., Reda M.A., Cognitivismo e Psicoterapia, Franco Angeli, Milano, 1980
Galimberti U., Dizionario di Psicologia, Utet, Torino, 2006